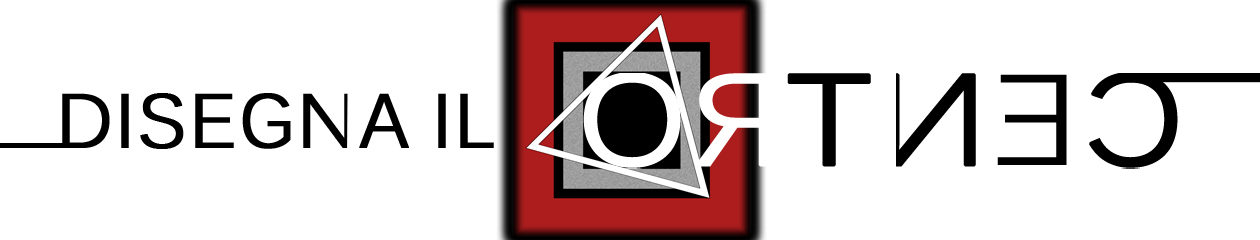“Un uomo con un piede amputato non si occupa del proprio abito perché non si cura del biasimo e della lode. Un forzato non ha più paura quando si trova su un punto elevato perché si disinteressa della vita e della morte. Chi non prova nessuna vergogna a ricominciare il proprio esercizio dimentica gli uomini.”1
Così lo stesso dolore che annulla la nostra vanità o le nostre piccole fobie (ma che può generarne di maggiori se mal vissuto), può permetterci di riprendere possesso di una vita più autentica:
“Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso?”2
Da queste parole emerge un’ottica del vivere che rifiuta un’esistenza passata SOLO nella ricerca del benessere individuale.
“L’uomo cerca di giustificare la sua esistenza non autentica con l’illusione di rimanere padrone del proprio destino e del mondo, e con l’altra illusione di aver quasi raggiunto il punto in cui vincerà le malattie, la disperazione e forse anche la morte. Così egli continua la sua via frivola e disonesta, senza pensare alla morte e senza prendere nessuna decisione che possa dare alla sua vita un orientamento rispetto alla morte.”3
Proprio quando interviene la sofferenza a guastare i nostri piani, ecco che ci viene data un’occasione per rimettere in discussione le nostre certezze e capire cosa realmente sia opportuno fare della nostra vita.
Nella prefazione all’edizione italiana del libro di Natsume Sōseki “Il cuore delle cose”, edita da Neri Pozza Editore, Gian Carlo Calza scrive a pag. 19,20: “A poco a poco, mentre il suo corpo sopravviveva alla malattia, Sōseki sentiva una nuova, più fresca linfa spirituale attraversarlo e provava uno stato di felicità e di comunione col mondo. Gli parve che la sua malattia fosse la fonte del suo rinnovamento e prese ad amarla come veicolo della ritrovata serenità, un veicolo simile, riteneva, alle ricorrenti crisi di epilessia che Dostoevskij chiamava il suo “male sacro”. La lunga degenza, l’estrema protratta debolezza, le pause riflessive, meglio meditative, la scoperta di una zona di serenità interiore condussero Sōseki a una più profonda e se possibile più convinta dedizione al suo destino spirituale. Il motto «soku ten kyōshi» (seguire il cielo e rinunciare a se stessi) diventa il fulcro della sua esistenza e della sua concezione della vita e perciò anche la malattia, e gli stati depressivi, oltre che veicolo di creatività, divennero sacri e inviolabili.”
“Può succedere che un corpo mutilato e infermo divenga il maglio per la forgiatura di uno spirito integro e risoluto.“
Molte sagge persone hanno provato un grande senso di riconoscenza per le loro malattie o sofferenze di ogni tipo; hanno scritto di questi patimenti e non in termini negativi. Per ognuno di loro si è trattato di veri e propri allenamenti spirituali, dove il corpo e la mente erano gli attrezzi ginnici; la preghiera o la meditazione l’acqua e il cibo rigeneranti; l’umiltà e la compassione gli effetti duraturi e salubri sullo spirito. Dico questo ben sapendo di correre il rischio di apparire un po’ troppo zelante e forse disturbante. È indubbio che nel momento di giocarsi per davvero la propria vita si generino forti turbamenti, ma se si considera che la morte è indispensabile per la venuta in essere della vita stessa, a costo del dolore, a quale pro disperarsi? Se si avesse davvero in odio la morte allora si dovrebbe avere allo stesso modo in odio anche la vita, questo perché tra vita e morte vi è una totale interdipendenza, tanto da rendere le due cose un’unità indissolubile. Dovremmo allora odiare i nostri genitori che ci hanno inoltrato in un ciclo di sofferenza duratura e dovremmo odiare noi stessi, per non aver ancora trovato il coraggio di farla finita.
L’unica via di uscita da questa folle illusione è nel dare a questo dolore la possibilità di operare in noi come farebbe un lassativo o un diuretico, capace di liberarci dalle scorie dell’io egotico (in contrapposizione con un io sano).
1 Zhuangzi cap. XXIII.
2 Vangelo secondo Luca 9:24-26.
3Thomas Merton, Diario di un testimone colpevole. Ed. Garzanti pag.231.